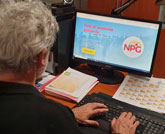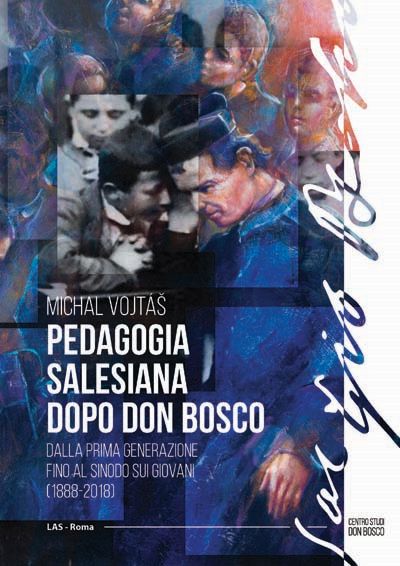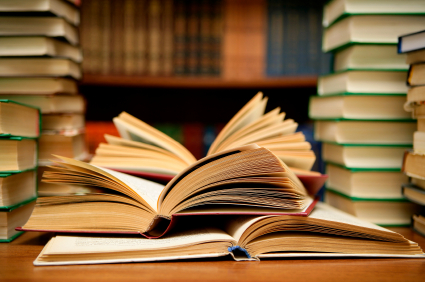Riccardo Tonelli
(NPG 1998-08-53)
Se i fatti sono contro le mie idee… peggio per i fatti: qualcuno lo dichiara senza mezzi termini. Molti educatori e altrettanti educatori della fede lo pensano, con la tranquilla coscienza che viene dal patrimonio culturale in cui sono cresciuti. Una lunga e consolidata tradizione educativa e pastorale li rassicura e aiuta a ributtare dubbi e incertezze. Essi sanno molto bene che non possiamo, per nessuna ragione, riconoscere nei fatti un principio indiscusso di verità. I fatti vanno giudicati e verificati dalle idee.
C’è un altro modo di pensare, diametralmente opposto: quello che fa coincidere ciò che è giusto, opportuno e conveniente con ciò che è constatato e realizzato. Lo slogan potrebbe essere tranquillamente capovolto: «Povere le mie idee quando sono contrarie ai fatti…».
A noi, che siamo rimasti (fortunatamente o sfortunatamente…) gente dalla valutazione facile, che andiamo in giro con la matita rossoblu sulla punta delle dita, viene spontaneo chiedersi: chi ha ragione? Da che parte conviene stare?
Passo dopo passo, cerco di suggerire una risposta, offrendo alcuni riferimenti di tipo generale e lasciando l’analisi della situazione, l’indicazione delle motivazioni e lo sviluppo dei progetti agli altri articoli del dossier.[1]
LA SOGGETTIVIZZAZIONE: UNA CHIARIFICAZIONE SUI TERMINI
Una cosa va ricordata subito, per evitare fraintendimenti.
I cambi culturali in atto non sono una faccenda che riguarda i giovani. Essi ci vivono dentro.
Per loro non è cambiato nulla. Il loro mondo è quello attuale. Non ne conoscono altri… se non per sentito dire, come quando si parla della stagione delle fate, delle streghe e dei draghi. Il cambio culturale è un problema nostro, di noi adulti che ci siamo trovati a vivere, quasi all’improvviso, in uno spazio di cui spesso ignoriamo lingua e cultura.
La soggettivizzazione è uno degli elementi più appariscenti di questa situazione culturale. Che cosa rappresenta?
La soggettivizzazione: un fatto
Ci vuole davvero poco per costatare quanto quell’insieme di atteggiamenti che noi raccogliamo sotto l’espressione di «soggettivizzazione» sia un dato di fatto, diffuso, pervasivo, insistito. Mille segnali confortano l’affermazione. Ne ricordo alcuni, quelli che sono più frequentemente ripetuti.
Viviamo in una stagione in cui predomina il «per me», rispetto all’«in sé». L’abbiamo persino fatto diventare un luogo comune, un inciso obbligato di ogni conversazione, per mettere le mani avanti e riconquistare il diritto di dire tutto quello che pensiamo e vogliamo.
Le appartenenze sono diventate deboli e soprattutto sono selezionate su criteri che hanno poco da vedere con il significato profondo dell’istituzione. La famiglia è riscoperta perché abbiamo bisogno di un riferimento funzionale, caldo e accogliente… a prezzi accessibili a tutte le borse. La scuola sta riportando consensi inediti, perché è riconosciuta uno spazio prezioso per incontrare persone, fare amicizie, progettare avventure per il tempo libero.
Persino la Chiesa non scatena più le resistenze di una volta: rappresenta un luogo prezioso di servizio al prossimo, di accoglienza e di incontro… siccome poi i problemi strettamente personali sono governati da orientamenti autonomi.
È sufficiente un confronto tra le espressioni della fede cristiana, così come sono espresse anche dai giovani più vicini e impegnati, e le formulazioni ufficiali della comunità ecclesiale… per convincere dell’urgenza di documenti sicuri, precisi, organici… da far apprendere con tutti i mezzi possibili.
Un ambito in cui la soggettivizzazione sta facendo sentire i suoi condizionamenti è quello del senso dell’esistenza. La domanda sul senso è spesso vissuta come ricerca di esperienze capaci di svelare e far sperimentare quello che spontaneamente ciascuno vive e costruisce. Il senso non si propone di conseguenza alle persone come un dato da scoprire e da accogliere, perché residente nella struttura della realtà. Esso invece è prodotto, nel frammento di vita che esprimiamo. Qualche volta, la soggettivizzazione dell’esperienza del senso è trascinata fino alle sue dimensioni estreme, nell’affermazione che quello del senso è solo un inutile, falso problema.
E l’elenco potrebbe continuare. Lo conosciamo a memoria e lo arricchiamo ogni volta che ci troviamo, tra adulti, a fare l’esame di coscienza sui giovani e a nome loro…
Qualche distinzione
I fatti restano indiscutibili. Serve poco tentare di sfumarli con l’indicazione di percentuali e di linee di tendenza. Vanno però interpretati, per valutarli in modo adeguato.
A questo livello, alcune distinzioni sono d’obbligo.
Soggettivizzazione e complessità
Per capirci incominciamo da ciò che sta alla radice della soggettivizzazione: la complessità sociale.
È definita complessa quella situazione sociale e culturale in cui si passa da un sistema sociale unificato, in cui le diverse istanze sono organizzate in un unico centro ordinatore, ad un sistema sociale raccolto attorno a diversi riferimenti, in cui convivono differenti e molteplici principi organizzatori.
Il pluralismo delle culture, dei valori, dei centri di potere e delle attività economiche rende l’universo sociale alquanto frastagliato e disaggregato in molti luoghi autonomi. La complessità nasce appunto da quest’articolazione che rende difficile l’identificazione della società come un tutto monolitico o, semplicemente, unitario.
In questo insieme complesso non esiste una visione della realtà o un sistema di valori che possa essere considerato egemone. Non esistono criteri di discernimento che siano valutati univoci e generali.
Ogni concezione del mondo e della vita, qualunque posizione etica, magari aberrante, ha diritto di esistenza e rivendica pari dignità con quelle più diffuse e ricche di validazioni storiche, culturali e sociali.
La constatazione influenza anche il rapporto personale con i valori. È difficile dichiarare che una persona non ha valori. Sembra più corretto riconoscere due cose: spesso i valori non coincidono (i giovani possono essere privi di quei valori che gli adulti considerano necessari; e viceversa); soprattutto manca un riferimento unitario, capace di selezionarli e organizzarli in sequenze coerenti.
La persona appartiene, infatti, a differenti raggruppamenti sociali con ruoli attivi e diversi. Riesce a convivere in questa situazione conflittuale, esprimendo un’appartenenza debole.
Il rapporto tra la persona e le diverse istituzioni diventa così poco vincolante e scarsamente incidente per la strutturazione della personalità. Le diverse istituzioni, anche quelle deputate al controllo e alle proposte, sono spesso considerate prevalentemente in termini strumentali e funzionali. La complessità ha profonde radici strutturali (divisione dei mezzi di produzione e gestione di quelli della comunicazione...). È importante ricordarlo per non ridurre l’analisi del processo educativo e la soluzione dei problemi che l’attraversano ad una semplice questione di buona o cattiva volontà.
Questo dato strutturale ricade sul piano culturale, producendo una trasformazione di valori, di stili di vita, di orientamenti cui ispirare la personale visione di sé e del mondo.
Soggettivizzazione come appropriazione personale
Spesso, quando parliamo di soggettivizzazione pensiamo proprio a questa situazione esasperata, che si traduce nel rifiuto di ogni oggettività e tende a trasformare il dato personale in una specie di idolo onnipotente.
Non è però l’unico significato dell’espressione e non possiamo escludere per principio la possibilità di altre utilizzazioni.
Pensiamo, per esempio, alla distinzione classica tra «valori» e «valorizzazioni». I valori sono un dato consistente e normativo, che sta prima di ogni persona e con cui le persone sono invitate a confrontarsi.
Quando una persona decide di accogliere nella propria esperienza un determinato valore e su esso valuta proposte e prende decisioni, essa trasforma il valore in una valorizzazione personale.
Passa dal piano oggettivo (quello dei valori) al piano soggettivo (quello delle valorizzazioni). Solo le valorizzazioni sono in grado di orientare l’azione e di giudicarla. I valori restano, di natura loro, lontani e astratti.
Certamente, il passaggio dal valore alle valorizzazioni non può essere considerato solo sul piano applicativo, come se uno dovesse «applicare» una formula chimica o matematica, per ottenere il risultato che vuole perseguire.
Nella traduzione dai valori alle valorizzazioni giocano moltissimi fattori, tutti sbilanciati dalla parte della soggettività di ogni persona: sensibilità, competenze, capacità di rischio e disponibilità all’intervento, comprensione dei fatti e categorie interpretative personali…
Le valorizzazioni orientano il comportamento della persona perché le forniscono i parametri per individuare ciò che per lei è utile e buono nella vita quotidiana. La dimensione pratica del valore non coincide necessariamente con quella ideale, sia per la difficoltà che ogni uomo incontra nell’essere fedele ai suoi valori ideali nella vita quotidiana, sia perché sovente molti di essi non sono principi di tipo etico.
Si potrebbe affermare, in qualche modo, che le valorizzazioni sono la necessaria soggettivizzazione dei valori. In questa ipotesi, la soggettivizzazione non è una degradazione dell’oggettività, ma la sua traduzione in fase operativa. Le valorizzazioni possono avere una connotazione meramente soggettiva quando non hanno più alcun riferimento al valore in sé, ma fanno del valore relativo l’universale.
Soggettivizzazione come riscoperta della centralità personale
Il termine «soggettivizzazione» esprime anche un altro significato, molto diverso rispetto ai primi due appena ricordati. Lo ripetiamo spesso e forse è questo il contesto più adeguato per riaffermarlo e considerarlo in modo nuovo.
Viviamo in una stagione in cui è facile scoprirci come orfani. Lo siamo per una ragione strana: l’eccessiva eccedenza di padri e di maestri… ci riduce a non poterne più riconoscere qualcuno come decisivo per fondare le ragioni di vita e di speranza. Le proposte, infatti, scorrono sempre di più in una logica poco strumentale e molto funzionale. Anche le cose che servirebbero solo a risolvere dei problemi contingenti di sopravvivenza quotidiana (come un’automobile per spostamenti rapidi, un fazzoletto contro il raffreddore, una crema che fa evitare arrossamenti di pelle…) diventano motivi di riconoscimento sociale, di prestigio, di qualità di vita.
In fondo, ogni proposta pretende di entrare nella nostra esistenza per farla da «padre e maestro».
Ci difendiamo, ritirandoci nell’isolamento della nostra intimità. La soggettività personale diventa uno dei pochi spazi, sicuri e governabili, dove poter dire, nella verità, chi sono e cosa ci sto a fare, a me stesso e agli altri. All’orfanità, prodotta dall’eccedenza di risorse e dalla crisi dei processi di trasmissione culturale, reagiamo recuperando la soggettività della nostra esistenza.
In questo caso, nonostante i limiti e i percorsi preoccupanti, la soggettivizzazione rappresenta una risorsa per sopravvivere in una stagione di complessificazione continua.
POSSIAMO SCRIVERE ANCHE OGGIUNA NUOVA «LETTERA A FILEMONE»?
In che direzione orientare la ricerca e soprattutto l’azione? Non voglio rispondere con espressioni sicure. È troppo seria la questione e sono troppo discutibili i personali punti di vista… da pretendere di risolverli io, con cinque pagine di ragionamenti. Preferisco un’altra strada, più responsabilizzante e impegnativa: quella del racconto di una storia. Il titolo la evoca: possiamo scrivere anche oggi una nuova «lettera a Filemone»? La storia è nota… anche perché l’ho già raccontata in uno degli editoriali di NPG dello scorso anno. La riproduco egualmente… per i distratti e gli smemorati. Aggiungerò poi qualche rapido commento, destinato a giustificare la scelta e ad orientare le decisioni personali sulla questione concreta che stiamo affrontando… tanto diversa da quella che Paolo ha affrontato quando ha scritto il suo bellissimo biglietto di raccomandazione a Filemone.
Una nuova «Lettera a Filemone»
Filemone aveva una bella casa, grande e accogliente, un gruzzolo di quattrini che gli permetteva di farla funzionare a dovere e, come ogni signore che si rispetti, i suoi bravi schiavi, che lo servivano e lo riverivano.
Paolo l’aveva convertito al cristianesimo in uno dei suoi viaggi. Con la conversione non aveva cambiato né casa né abitudini. Si era tenuto i suoi schiavetti e si godeva i suoi soldi, anche perché i primi li aveva comprati a prezzo giusto e i secondi se li era guadagnati onestamente. Al ritmo normale della sua vita aveva solo aggiunto qualche impegno in più... Era diventato ancora più onesto negli affari, faceva tutte le elemosine che poteva, amava le persone che incontrava e trattava non troppo male i suoi schiavi. La sua casa, poi, era ormai la casa di tutti i cristiani del posto e di quelli che passavano da quelle parti. Lì si radunavano a pregare, a mangiare un boccone e a fare un po’ di festa. Come usava a quei tempi, nella sua casa veniva anche celebrata l’eucaristia della comunità.
Riunione, festa e celebrazione eucaristica erano d’obbligo quando da quelle parti passava Paolo. Filemone lo considerava un padre, nel senso pieno della parola. Non c’entrava niente con i suoi genitori, ma Paolo gli aveva fatto scoprire la gioia del Risorto, gli aveva spalancato il cuore alla vita. Veramente, l’aveva generato nello spirito... ed è la cosa che conta di più. Aveva proprio il diritto di chiamarlo suo padre.
Anche quella sera, per festeggiare il passaggio di Paolo in zona, nella casa di Filemone si era radunata molta gente.
Avevano mangiato una cena da gran festa. Poi, finito di mangiare, erano partiti i ricordi. Paolo era al centro della conversazione. Parlava della sua esperienza di Gesù, della grande passione che lo portava in giro per il mondo, tra rischi e pericoli d’ogni sorta, per annunciare il Vangelo a tutti. Non poteva tacere la novità degli ultimi tempi: i nemici di Paolo aumentavano, si sentiva minacciato. I suoi antichi compagni di religione non gli perdonavano davvero il cambio di bandiera. Pazienza... rinunciare allo zelo di ogni buon fariseo... ma mettersi a proclamare con foga che la legge non serve più a dare vita e speranza, perché solo in Gesù possiamo essere liberi e salvi... Con idee del genere, una brutta fine non gliela toglieva nessuno: era solo questione di giorni o di opportunità.
Anche quella sera, come era capitato altre volte, prima dell’ultimo saluto, Paolo consacra il pane e il vino e lo distribuisce ai commensali. Nel pane condiviso il ricordo del Crocefisso risorto diventa evento di salvezza per tutti e impegno di responsabilità nuove. In questo gesto, solenne e speciale, i cristiani sanno di obbedire all’invito di Gesù, ripetendo l’esperienza che Gesù aveva vissuto in quella cena famosa, l’ultima consumata con i suoi discepoli.
La storia di Filemone assomiglia a quella di tanti altri cristiani: ci svela uno spaccato importante della vita delle prime comunità ecclesiali. Quella sera, però, è successo un imprevisto. Esso offre a Paolo l’occasione di scrivere un biglietto di raccomandazione, tanto importante, da farci venire la voglia di continuare a scrivere anche oggi cose del genere.
Con un po’ di fantasia, non facciamo fatica ad immaginare cosa è capitato quella sera di tanto sconvolgente.
Filemone aveva molti schiavi. Nessuno gli aveva contestato il diritto di tenerseli: né prima né dopo la conversione. Di uno di loro sappiamo anche il nome: Onesimo. È il protagonista dell’avvenimento che ha dato origine alla lettera di Paolo a Filemone.
Paolo parlava. Gli invitati lo ascoltavano con devota attenzione. Diceva delle cose bellissime. Tutti pendevano dalle sue labbra. Gli schiavi, invece, pensavano al loro lavoro. Avevano solo fretta di arrivare alla conclusione della serata. Dovevano sparecchiare, ripulire e ordinare la casa. Domani mattina doveva essere lucida e splendente, come sempre. Stava facendosi ormai notte fonda e si allontanava il tempo del riposo meritato.
Ad un certo punto però Onesimo si ferma di colpo. «Che cosa sta dicendo Paolo?». «Dai, Onesimo, sbrigati», lo sollecita un compagno di sventura. «Fammi ascoltare bene. Abbi pazienza... ma non voglio perdere questo passaggio».
Diceva Paolo: «Gesù, nella sua morte e resurrezione, ha distrutto il muro che teneva separati gli uomini tra loro. Adesso, non ci sono più né greci né giudei, né uomini né donne... non ci sono più né schiavi né liberi. Siamo tutti fratelli, nell’amore che Dio ci porta».
Le parole di Paolo risuonano sempre più forti nel cuore di Onesimo. «Non ci sono più né schiavi né uomini liberi... siamo tutti fratelli, tutti figli dello stesso Padre che sta nei cieli».
Non ne può più. Lui è schiavo. Il ricordo della libertà è lontano, legato ad una terra sperduta ai confini del mare. Non può restare in questa situazione. Se Dio lo ama, ha diritto alla libertà.
È ormai notte fonda. Tutti dormono. Si alza dal suo giaciglio e scappa. Vuole godere della libertà che Dio gli ha regalato.
Scappa, di corsa, lontano dalla casa di Filemone... Verso dove? La sua casa, quella piena di libertà, è irraggiungibile. Non sa dove andare.
Si ricorda di Paolo. Sa che è rimasto in città. Corre da lui. Lo tira giù dal letto. Si presenta: «Sono Onesimo. Ero schiavo nella casa di Filemone. Sulle tue parole ho cercato la libertà. Sono qui».
Si aspettava di tutto. Ma le parole di Paolo... quelle proprio no, davvero. Paolo lo rimprovera duramente: «Non si può. Gli schiavi devono obbedire ai loro padroni. Devi ritornare subito da Filemone. Subito».
«Ma tu hai affermato che non ci sono più né schiavi né uomini liberi. Siamo tutti liberi. Dio ci ha liberati. E allora?».
La risposta di Paolo lo butta in un mare di amarezza. «È vero... questo è il progetto di Dio. Gesù l’ha realizzato tutto. Ma ora sta solo germinando... come un piccolo seme. Devono passare ancora lunghi inverni prima che il seme fiorisca in albero grande. Dobbiamo attendere: con pazienza. Onesimo, devi tornare».
«Non posso. Filemone mi punirebbe. La legge prevede la morte per lo schiavo che fugge. Non posso».
Paolo non ha dubbi. «Filemone è un bravo cristiano. Poi... mi vuole bene e ha tanti debiti nei miei confronti. Non ti preoccupare. Ti scrivo un biglietto di raccomandazioni. Torna da Filemone con il mio biglietto e vedrai che tutto si metterà per il meglio. Mi raccomando però: obbedienza e rispetto per il tuo padrone».
Onesimo si convince a tornare. Non ha altra scelta. Il sogno è durato il baleno di un lampo. Torna la notte, fredda e nera.
Paolo prende carta e penna e, di suo pugno, stende quattro righe di raccomandazione. Il documento è riportato nel Nuovo Testamento: la lettera a Filemone. Si legge tutta d’un soffio, tanto è bella, concreta, piena di amore e di coraggio.
«In Cristo ho piena libertà di comandarti ciò che devi fare. Preferisco però pregarti in nome della carità, così qual io sono, Paolo, vecchio, e ora anche prigioniero per Cristo Gesù; ti prego dunque per il mio figlio, che ho generato in catene, Onesimo, quello che un giorno ti fu inutile, ma ora è utile a te e a me. Te l’ho rimandato, lui, il mio cuore.
Avrei voluto trattenerlo presso di me perché mi servisse in vece tua nelle catene che porto per il vangelo. Ma non ho voluto far nulla senza il tuo parere, perché il bene che farai non sapesse di costrizione, ma fosse spontaneo. Forse per questo è stato separato da te per un momento perché tu lo riavessi per sempre; non più però come schiavo, ma molto più che schiavo, come un fratello carissimo in primo luogo a me, ma quanto più a te, sia come uomo, sia come fratello nel Signore.
Se dunque tu mi consideri come amico, accoglilo come me stesso. E se in qualche cosa ti ha offeso o ti è debitore, metti tutto sul mio conto. Lo scrivo di mio pugno, io, Paolo: pagherò io stesso. Per non dirti che anche tu mi sei debitore e proprio di te stesso! Sì, fratello! Che io possa ottenere da te questo favore nel Signore; da’ questo sollievo al mio cuore in Cristo!».
La lettera è commovente. A gente come noi... fa specie però costatare che Paolo non dice a Filemone nulla a proposito di schiavitù. Non lo invita a rimettere in libertà né Onesimo né i suoi amici. Tratta Onesimo persino come una cosa che si desidera, che appartiene a qualcuno, che si può regalare.
Questi modelli culturali ci fanno paura. Il Vangelo c’è diventato troppo familiare per rassegnarci a ragionare così. Per Paolo, come per la gente del suo tempo, invece, la cosa era pacifica. Faceva parte della cultura del tempo: quella «carne» in cui Dio si è fatto parola e volto, per diventare nostro signore e salvatore.
C’è una novità, però, grande come l’abisso dell’amore. Senza mettere sotto questione la logica perversa della schiavitù, Paolo parla di sé, di Onesimo e di Filemone con una tenerezza che rende presente quella di Dio per noi.
Questo è il bello dell’esperienza cristiana. L’incarnazione è sempre salvezza. Assumendo la nostra quotidiana carne, Dio ci fa passare da morte a vita.
Per questo, l’amore di Dio, piantato nel cuore dei problemi, li scarnifica e ne fa esplodere tutte le contraddizioni. Un po’ alla volta, i cristiani l’hanno capito e hanno lottato contro la schiavitù e contro le altre ragioni di discriminazioni culturali e sociali.
In concreto
Ho raccontato la storia di Onesimo e di Filemone, aggiungendo qualche particolare narrativo al testo ufficiale della Lettera di Paolo, per ricordare un modello di soluzione ai problemi culturali, che può far testo anche oggi.
Paolo aveva tra le mani un problema gravissimo, una di quelle patate bollenti che ci piacerebbe rilanciare subito agli altri. Per lui la schiavitù e la sua logica erano qualcosa di pacifico. Non la metteva sotto giudizio proprio perché non poteva immaginare alternative, nel crogiuolo dei modelli culturali in cui si riconosceva. Non poteva però consegnare Onesimo alle leggi feroci degli schiavi che tentavano la fuga. Aveva scoperto il dovere imprescindibile di amarlo, di difenderlo, di farlo amare sopra ogni cosa. Per Paolo, Onesimo era uno schiavo… ma era figlio di Dio, pieno della libertà e grandezza che Gesù aveva restituito nella sua morte violenta a tutti i figli di Dio. Che fare?
Ecco la risposta: amare lo schiavo Onesimo come Dio ci ama; continuare la grande esperienza dell’incarnazione, invitando Filemone a scoprire il volto suo e quello di Dio nel volto dello schiavo.
E se provassimo anche noi a scrivere oggi qualche nuova lettera a Filemone... in questa stagione in cui molti dei modelli culturali in voga ci fanno una gran paura e non sappiamo dove sbattere il capo? Forse la soggettivizzazione e i rischi ad essa connessi non sono davvero peggio della schiavitù...
Non possiamo giudicare la soggettivizzazione e i rischi che da essa derivano, con le categorie saccenti di chi sa in anticipo dove sta il torto o la ragione, solo perché possiede delle unità di valutazione che gli vengono dalla tradizione. Nello stesso tempo però non possiamo accettare il dato di fatto solo perché rappresenta un patrimonio incontrollabile della cultura attuale.
Scrivere nuove «Lettere a Filemone» potrebbe significare attivare, anche in questo caso, un’operazione a carattere ermeneutico: giudicare assumendo in modo incondizionato, ripensare il già sperimentato alla luce del nuovo e pensare il nuovo che sta emergendo dalla provocazione di quello che abbiamo per tanto tempo considerato come irrinunciabile.
Si tratta, in altre parole, di interpretare le linee emergenti della cultura attuale con una disponibilità piena e amorevole, riconoscendo i segni di speranza di cui la nuova situazione è carica, e di valutare il tutto alla luce del progetto di esistenza, che ci viene dal lungo cammino della tradizione educativa e pastorale. In questa operazione diventa possibile il tentativo di ripensare il progetto educativo e pastorale dal contributo (positivo e negativo) della cultura attuale, per rendere la proposta «espressiva» e «salvifica».
Come si nota, suggerisco la necessità di superare, anche davanti alle provocazioni offerte dalla soggettivizzazione, quelle «reazioni» educative purtroppo frequenti e comuni: il rifiuto o la rassegnazione. Rifiutiamo (più o meno consapevole) il nuovo se lo leggiamo e lo interpretiamo da quello che abbiamo già sperimentato, che possediamo, in cui ci riconosciamo.
Scegliamo, al contrario, la rassegnazione (più o meno motivata) quando l’attenzione al nuovo e la legge del «cambiare» per essere riconosciuti, diventano criterio valutativo irrinunciabile.
La consapevolezza del profondo intreccio esistente tra «cultura» e «evento», chiede il discernimento e l’invenzione. E chiede la capacità di riesprimere quest’evento per la nostra vita all’interno di eventuali nuovi modelli culturali. In situazione di pluralismo, com’è quella che stiamo vivendo, quest’operazione non ha solo un movimento diacronico (dal passato all’oggi); ne esige anche uno sincronico (in rapporto alle differenti situazioni).
TRA OGGETTIVITÀ E SOGGETTIVIZZAZIONE...
Il lettore attento ha certamente notato quanto il titolo di questo contributo assomigli e quanto si differenzi rispetto a quello del dossier. I termini sono gli stessi, ma c’è un’aggiunta notevole, che dice già una precisa scelta di campo: nel dossier l’ipotesi che la soggettivizzazione sia da considerare più una risorsa che un problema è ancora molto interlocutoria (espressa da un punto di domanda); nel mio articolo è invece una proposta (giacché è stato tolto il segno grafico d’interrogazione).
Non è indicato nel titolo lo strumento che permette alla soggettivizzazione giovanile di passare da «problema» a «risorsa». È implicito ma evidente: l’educazione. Attraverso precisi interventi educativi ciò che generalmente è considerato un problema può diventare una preziosa risorsa.
In questa logica, suggerisco alcuni interventi.
Un modo di dire la propria fede e la propria speranza
Incomincio con la prima questione, quella che spesso prende il sopravvento nelle preoccupazioni di molti educatori impegnati nell’ambito pastorale.
Si dice spesso: i giovani non conoscono più le verità della fede, e quando tentano di esprimerle dicono grossi strafalcioni teologici. Qualcuno poi rincara la dose: non conoscono neppure i dieci comandamenti… sfido che poi hanno poche remore etiche. La reazione è pronta: bisogna far apprendere con insistente fermezza ciò che va conosciuto a tutti i costi.
Come si vede, si reagisce alla soggettivizzazione cercando di riportare nel terreno consolidato dell’oggettività. In questa preoccupazione sono invocati e lodati gli strumenti dove tutto sembra ormai risolto.
Sono convinto della possibilità di immaginare altri percorsi. E li suggerisco con qualche rapida battuta.
La dottrina della fede
Noi possediamo espressioni consolidate per dire la nostra fede. Ci vengono da lontano. Alcune hanno origine direttamente dai tempi della prima comunità cristiana, come manifestazione dell’esperienza fatta con Gesù. Altre sono andate maturando nella coscienza della Chiesa nel lungo cammino dei secoli, e le incontriamo ormai, precise e solenni, nei documenti ufficiali. Altre, infine, propongono, con l’autorevolezza che riconosciamo al Papa e ai Vescovi, il livello oggi raggiunto dalla fede ecclesiale, su temi e problemi importanti.
Tutte esprimono quel modo comune per dire la fede, che ci permette di credere in compagnia con i cristiani dei tempi passati e con quelli sparsi nei quattro angoli del mondo.
Il credente deve imparare a dire la sua fede nella professione di fede della Chiesa, perché la Chiesa è il luogo della verità, nell’unità e nella carità. Il riferimento alle formule della fede ecclesiale e il confronto con i documenti in cui sono contenute, non vanno pensati però come un progressivo avvicinamento della personale professione di fede ad un codice già confezionato e concluso di affermazioni, da ripetere con la preoccupazione di non sbagliare neppure una virgola.
È certamente importante riconoscere la funzione autorevole dei testimoni della fede e della Parola. L’esigenza è decisiva sempre, per rispettare il progetto di Gesù sulla Chiesa; e lo è in modo particolare oggi, in un tempo in cui ci viene facile e spontaneo sostituire le nostre parole a quelle con cui i credenti hanno confessato la loro fede e la loro speranza. Non possiamo però immaginare che questo riconoscimento funzioni solo quando affidiamo al magistero il compito di controllare quale sia ancora la distanza tra la formulazione ufficiale e quella personale. In questo modello, la confessione di fede assomiglia molto all’ascolto di una bella sinfonia musicale, in una camera insonorizzata e con strumenti di registrazione raffinati.
Tutto è gradevole, perché la riproduzione è perfetta... e quando non è così, si richiede l’intervento dei tecnici per riparare i guasti.
Un percorso educativo
La persona del credente è sempre al centro della sua professione di fede. Dice parole che si avvicinano al mistero con la stessa forza coinvolgente dei simboli dell’amore e della poesia. Quando pretende di descrivere il mistero in modo sicuro e definitivo, con le sue parole o con quelle prese a prestito dai documenti ufficiali, corre il rischio di perdersi nella ricerca affannosa di qualcosa che non riuscirà mai a trovare.
La meta è chiara. Siamo invitati a crescere verso le espressioni consolidate e verso l’obbedienza sincera e cordiale nei confronti dei fratelli che hanno il compito di sostenere nella verità la nostra ricerca. Tutto questo rappresenta il punto d’arrivo del nostro cammino, la tensione verso la maturità piena, il confronto che giudica e inquieta il nostro quotidiano procedere.
Come arrivarci? Sono convinto che la reazione all’oggettività fredda e ripetitiva e alla soggettivizzazione anche nelle espressioni della nostra fede, stia nell’educazione a ritrovare il significato delle parole che diciamo, per confessare la nostra fede, collegando invenzione e fedeltà. Diremo sempre la fede con le nostre parole, anche quando riusciremo a dirla con le parole che altri hanno costruito per noi, nella loro fede. Non possono non restare «parole nostre», perché solo così dichiariamo nella verità la nostra fede.
Spesso le parole saranno tanto nostre, che ci metteremo del nostro: battute, espressioni, inflessioni di voce, qualche virgola di troppo. Non possiamo essere in crisi per questo: perché nessuna parola potrà mai essere tanto perfetta da dire tutto il mistero. Ci lasceremo invece inquietare dalla necessità di far progredire la nostra confessione di fede, fino ad esprimere la nostra passione e la nostra speranza nel modo che risuona, alto e solenne, nella comunità ecclesiale.
Tutto questo per una ragione semplicissima e affascinante, che non mi stancherò mai di sottolineare: c’è una differenza sostanziale tra il dire la fede e ripetere una formula di chimica o un teorema di matematica. Nel secondo caso dico cose vere e autentiche solo quando ripeto esattamente ciò che ho appreso. Nel primo, invece, sono nella verità e nell’autenticità quando dico io, con la vita e con le parole che so elaborare, quello che ho sperimentato del dono affascinante dello Spirito di Gesù.
Il confronto con dati capaci di provocare
In una cultura dell’oggettività, il diritto e la possibilità di collocare una proposta dove si cerca e si produce il senso della vita era segnato prevalentemente dalla discriminante vero/falso. Quando una proposta era oggettivamente vera, possedeva il diritto di essere offerta con decisione. Al diritto del proponente corrispondeva il dovere di ogni persona saggia di accogliere. Al massimo, difficoltà e resistenze erano tollerate sul piano della prassi spicciola, per rispettare la costitutiva debolezza dell’uomo.
Oggi, le logiche sono molto diverse. La discriminante è tracciata sulla frontiera della significatività. Solo quello che è sentito come soggettivamente espressivo, perché si colloca dentro gli schemi culturali che una persona ha fatto ormai propri, merita di essere preso in considerazione. Ci s’interroga sulla verità solo dopo aver risposto affermativamente alla domanda della significatività. Quando la proposta è avvertita come poco espressiva, è fuori gioco, perché è fuori del gioco personale.
Purtroppo, la via della verità e quella della significatività sono sperimentate in pratica come alternative e contrapposte. E se invece tentassimo una riconciliazione, ancora una volta in quella prospettiva ermeneutica che sto continuamente rilanciando? Possiamo, in altre parole, percorrere la via della significatività per accedere a quella della verità: fare proposte, mettendo le persone a contatto con «dati» capaci di mettere in crisi la soggettività, spalancando verso l’ulteriore e l’inedito.
L’affermazione spalanca su due questioni complementari: quali sono questi dati e come possono diventare educativi. Provo a ricordare qualcosa, sottolineando quello che molti di noi conoscono e praticano quotidianamente.
Fatti che provocano
Incomincio con la prima questione: in una cultura come è la nostra, esistono ancora dei fatti capaci di provocare e mettere in crisi?
Basta guardarsi d’attorno per rispondere con un sì rotondo, anche se ci preoccupa la constatazione di come questi fatti siano facilmente manipolabili e programmabili ad arte.
Tento un elenco.
Abbiamo avuto tutti la fortuna di incontrare persone che lasciano il segno. Sono una traduzione viva di parole solenni. Ci insegnano quali sono le cose che contano, come possiamo vivere la nostra esistenza in termini maturi e responsabili. Ci dichiarano, spesso senza eccessive parole, come e perché continuare a sperare.
La stessa cosa si può dire per alcuni testi, carichi di una capacità evocativa formidabile. Basta pensare ad alcune pagine del Vangelo: anche oggi continuano a suscitare un’onda di conversione alla responsabilità che si fa servizio, ad un amore che sa governare persino la libertà.
In altri contesti ho ricordato due vie privilegiate: la morte e l’amore incondizionato. L’esperienza della morte e quella della vita non sono due esperienze alternative. Solo assieme, nella stessa trama di cui è tessuta la nostra esistenza, riconducono, in modo autentico, a quel limite esistenziale che è la nostra verità. Penso, per esempio, all’amore gratuito che si fa servizio, alla disponibilità a sostenere, in una presenza silenziosa e accogliente, il dolore e la sofferenza, fino a riscattare il suo significato per la vita di tutti, alla passione per la vita e la libertà, che conduce a sacrificare la propria esistenza come dono per quella di tutti.
Tutti questi fatti (e i tanti altri che ogni educatore riconosce d’esperienza diretta) hanno in sé una vivacità umana così ricca e imprevista, da diventare come segnali indicatori di una ragione ultima e misteriosa dell’esistenza. Ci offrono un modo di essere uomini e donne che rilancia verso qualcosa che ci supera e ci è stato donato.
Interventi educativi
L’esperienza comporta prima di tutto un contatto vitale con la realtà, nella sua forza provocante che, in qualche modo, precede l’atteggiamento personale. Questo contatto deve essere non troppo lontano e difficoltoso, per non apparire estraneo; né troppo familiare, perché altrimenti non provocherebbe a sufficienza. In questo confronto disponibile, che giudica la nostra soggettività, è dischiusa la possibilità di prospettive sorprendenti, nuove e promozionali. Questo contatto, però, non è solo fredda oggettività. Esso è sempre riempito dai ricordi, dalle sensazioni e dai progetti di chi fa esperienza. Esperienza è quindi interpretazione soggettiva di dati oggettivi. Interpretando (operando cioè sul reale attraverso il nostro pensiero), noi identifichiamo ciò di cui abbiamo fatto esperienza. Da una parte, infatti, raccogliamo ed evidenziamo gli elementi d’interpretazione che trovano la loro ragione e fonte nella realtà sperimentata, che il nostro pensiero rende trasparente; dall’altra, colmiamo questa realtà della nostra soggettività, fino al punto che attraverso il nostro pensiero interpretante noi abitiamo in un mondo diverso da quello abitato da persone che hanno fatto esperienze differenti dalle nostre.
È importante far notare che questa interpretazione del vissuto non è un fatto di ordine puramente razionale, ma coinvolge tutta la persona, anche se richiede un momento di riflessione sull’interpretazione esistenziale, per favorire l’integrazione riflessa del vissuto.
Liberare la soggettività
Le lunghe riflessioni precedenti hanno cercato di ritagliare un’alternativa al confronto tra oggettività e soggettivizzazione e si sono impegnate a rendere praticabile il modello registrato. Chi le legge tra le righe, s’accorge che il superamento dell’alternativa potrebbe essere rappresentato da una proposta del genere: d’accordo con la centralità irrinunciabile di ogni persona… a condizione che ciascuno si impegni a liberare la propria soggettività.
Quello che preoccupa, dal punto di vista educativo, non è la troppa attenzione verso la propria soggettività, come non possiamo preoccuparci di un amore e di una fiducia verso la vita che consideriamo eccessivi. Preoccupa la qualità della soggettività. Essa si porta dentro i suoi limiti, invalicabili come esigenza d’autenticità.
Siamo impegnati ad aiutare ogni persona a conquistare una soggettività autentica, per potersi esprimere e progettare nella verità. Questa è un’impresa di restituzione. Tutti, attorno a noi, infatti, inneggiano alla nostra libertà e responsabilità. L’una e l’altra sono, però, sempre di più, oggetto di rapina. Riconquistare la soggettività richiede, di conseguenza, la riconquista di quanto c’è stato, tanto spesso, defraudato. L’aiuto diventa «restituzione».
La scoperta di limiti invalicabili
La scoperta della soggettività e il rifugio in essa non è una decisione suicida. Ne sono consapevoli tutti, anche se non trovano né cercano le parole per esprimere questa constatazione. In fondo, essa risponde ad un’esigenza di realizzazione personale.
La possiamo valutare come involutiva o ne possiamo elencare i disturbi maturativi di cui è attraversata. Essa resta, come un dato innegabile di decisione personale. Combatterla… nel nome della realizzazione di sé mi sembra un’impresa inutile e improduttiva. Mi chiedo se invece non può essere controllata meglio e superata nelle sue espressioni più distorte, proprio nel nome di quella realizzazione che sta a cuore.
La scoperta del significato della soggettività non può trascinare alla conclusione che ormai non hanno più senso il controllo, le norme, quel pacchetto di esigenze che formano il confine insuperabile dentro cui possiamo dire la nostra voglia di felicità.
Ci sta a cuore la vita e la vogliamo costruire in un orizzonte pieno di felicità: questo è il riferimento fondamentale su cui si misura l’impegno educativo e pastorale. Non possono esistere degli spazi in cui ridimensionare la pretesa né è possibile immaginare un prezzo da pagare, volenti o nolenti, per ottenere quest’obiettivo, una specie di condizione esterna, come è quella che fa dire a qualche educatore: «Vuoi la felicità… d’accordo, intanto però sacrificati se la vuoi conquistare». L’enfasi inarrestabile sulla soggettivizzazione rompe questa prospettiva, come un torrente in piena sfascia gli argini che tentano di contenerlo.C’è un’alternativa. E va riconquistata.
La vita è piena e la felicità è assicurata quando la qualità della vita è rispettata. Il confine è interno: ciò che cerco e che ardentemente mi sforzo di raggiungere si porta dentro un suo limite costitutivo. Chi lo ignora o cerca di superarlo sull’onda dell’entusiasmo, si priva, con le sue stesse mani, della possibilità di raggiungere quanto gli sta a cuore.
Lo so che un’affermazione come questa è tutt’altro che pacifica. Si scontra con i modelli antropologici di coloro che fanno della legge il principio del bene e del male, e di coloro che spingono verso il soddisfacimento incontrollato di ogni desiderio. La rilancio però con forza nel nome della qualità di vita che l’esperienza cristiana più matura ci suggerisce.
La vita umana si esprime e trova la sua energia creatrice nell’incontro-scontro tra la potenza del desiderio e la costrizione del limite, quell’insieme di norme, di codici e, quindi, di forme che fissano le possibilità legittime in cui l’azione umana può manifestarsi. Se il desiderio è lasciato libero di esprimersi e non incontra delle costrizioni che lo incanalano all’interno di particolari forme di vita, esso rivelerà la sua devastante potenza distruttrice.
Il confronto con l’umanità di Gesù e il suo messaggio non ci suggeriscono solo il modello antropologico globale. Ci aiutano anche a decifrare, in concreto, su quali limiti debba attestarsi il desiderio di vita e di felicità.
- L’esodo verso la solidarietà.
Per dare realizzazione alla nostra voglia di vita e di felicità, è sufficiente rinchiudersi nello schema rigido della propria soggettività o, al contrario, solo uscendo da noi stessi, in un esodo che c’introduce nel mondo provocante dell’altro che ha bisogno di noi… possiamo veramente crescere come uomini e donne pienamente riusciti?
Il Vangelo ci suggerisce un modo preciso di essere e di comprenderci: la disponibilità, continua e concreta, a «farsi prossimo».
Nella meditazione della storia evangelica del buon Samaritano, possiamo così riconoscere di costruire la nostra esistenza solo se accettiamo di uscire da noi stessi, decentrandoci verso l’altro. L’esistenza nella concezione evangelica è quindi un esodo verso l’altro che ha il volto concreto di ogni persona incontrata, anche a caso, sulle strade della nostra vita.
Camminiamo «a testa dritta» quando sappiamo piegare tutta la nostra vita a chi ci tende la mano. Diamo volto e parola a Dio, lo riconosciamo presente nella nostra esistenza e lo mettiamo al centro di tutto, quando lo riconosciamo nel fratello che ci tende la mano.
Questa è la logica dell’amore: esistiamo per amore e siamo impegnati a costruire vita attraverso gesti d’amore.
Certo, questa prospettiva non è un modo di affrontare i problemi, da esprimersi soprattutto con parole raffinate e sagge. Ha senso ed è proponibile solo se è sperimentato nei vissuti concreti delle persone che ci circondano. Ritorna, di conseguenza, quell’esigenza propositiva tante volte raccomandata: fare proposte, facendo fare esperienze.
- L’esperienza della finitudine.
Il secondo riferimento è dato da quell’esperienza che mi piace chiamare «la finitudine».
Sul tema della finitudine NPG è tornata spesso. Si tratta di un’esperienza importante perché ci permette di essere restituiti alla verità di noi stessi. Spendo qualche rapida battuta per ricordare il suo significato.
L’uomo che vuole possedere la propria vita è posto di fronte ad un’alternativa radicale. Può farsi volontà di se stesso, impennandosi in una volontà di potenza, di autoaffermazione, in una pretesa di autosufficienza. Oppure può scoprire che la ragione decisiva della propria esistenza e il fondamento della propria felicità consiste in un oltre da invocare e da accogliere. Questa è l’esperienza che si apre ogni giorno sulla nostra appassionata ricerca di senso: il grido presuntuoso della conquista o le mani alzate nell’invocazione e nell’accoglienza. È facile e doveroso pensare alla parabola del fariseo e dell’esattore delle tasse (Lc 18, 9-14).
Gesù l’ha raccontata per offrirci un progetto di identificazione concreto, sollecitandoci a decidere da che parte vogliamo stare.
Avvertiamo di procedere a entusiasmi e a incertezze, in un progetto sognato e mai realizzato. Ci scopriamo capaci di perseguire una qualità diversa di vita, anche quando ci costatiamo prigionieri dei nostri tradimenti. Sentiamo di doverci giocare quotidianamente tra vita e morte, perché appassionati di vita. Questa costatazione, fatta esperienza, è la verità dell’uomo: l’esperienza della povertà, dell’inquietudine, della fragilità, del procedere incerto a tradimenti e a ritorni, in una parola, l’esperienza della finitudine.
Dall’esperienza della finitudine possiamo cercare di uscire attraverso la saccente presunzione di chi pensa di farcela da solo, aumentando eventualmente la dose dell’impegno e l’esercizio raffinato della sua sapienza. Di finitudine possiamo anche soccombere: quando diventa motivo di disperazione o quando spinge ad ubriacarsi di disimpegno e di frastuono.
Possiamo però sprofondarci nell’invocazione, in compagnia dell’esattore delle tasse della parabola evangelica.
Chi sa vivere così l’esperienza della finitudine, come verità di se stesso, sofferta e scoperta, e alza al Signore il grido della sua vita, ritrova la gioia di vivere e la libertà di sperare. Riconosce di poter invocare il suo Signore non perché ha raggiunto la perfezione, ma perché ne ha un desiderio sconfinato. Solo lui è il fondamento, la ragione decisiva della propria vita.
Convive, nella pace e nella gioia, con la propria finitudine, perché si sente nell’abbraccio accogliente di Dio.
L’educatore come testimone del limite
Le esigenze della solidarietà e il confronto con l’esperienza della finitudine ci aiutano a comprendere e riscrivere una delle funzioni più urgenti, affidate all’educatore.
L’educatore non può esercitare la funzione scomoda di ricordare gli elenchi di norme e valori che i giovani distratti tendono a dimenticare, né può esercitare il compito di controllare e punire i trasgressori, come se lui fosse al di sopra delle parti per il ruolo che sta ricoprendo.
Un modo di fare come questo lo metterebbe in crisi perenne. L’adulto, che trovava nel surplus di esperienze la legittimazione della sua funzione educativa, avverte di non aver nulla da dire e nessuno cui comunicare quel poco che pensa di poter dire. Da una parte, infatti, la consapevolezza della provvisorietà e della relatività attraversa anche la sua esistenza, perché anche lui sta diventando, come tanti altri, figlio di una cultura della soggettivizzazione. Dall’altra, le sue parole cadrebbero nell’indifferenza. È, infatti, scarso anche l’interesse a ricevere qualcosa da altri, se questo soggetto non è sperimentato appartenente al proprio ristretto gruppo. Anche le agenzie, tradizionalmente incaricate di questa responsabilità (scuola, famiglia, chiesa...), sono oggi in crisi. Come appare dalle ricerche più recenti, esse recuperano credibilità e consenso solo quando sanno presentarsi come luogo di relazioni primarie soddisfacenti. In fondo, esse funzionano solo quando, rinunciando alla loro specificità, delegano ad altri la trasmissione dei «contenuti», per riappropriarsi quella di assicurare interazioni.
L’educatore, al contrario, sta sempre dalla parte della vita. Nel nome della vita, della sua pienezza e della felicità, ricorda quelle esigenze irrinunciabili (il realismo della finitudine e i diritti della solidarietà), che misurano e controllano l’esplosione del desiderio soggettivo. «Nomina» queste esigenze con il coraggio che gli nasce dentro dall’amore e con la trepidazione di chi sa di pronunciare parole che lo riguardano direttamente in prima persona.
Il coraggio e la trepidazione nutrono la sua proposta di quella speranza che fa del limite, accolto e sperimentato, qualcosa di continuamente superabile. La sua fedeltà verso le esigenze della vita è radicata nel passato, ma è continuamente aperta verso il futuro. Egli fa quindi sperimentare, tra le pieghe del presente, un prezzo di quel futuro, dove finalmente ogni limite sarà superato e la voglia di vita e di felicità potrà esplodere in modo definitivo.
Ogni persona sarà così restituita alla ricchezza della propria soggettività.
NOTA
[1] La mia proposta ha alla radice una lunga riflessione redazionale e risente, per questo, di scelte e orientamenti che i lettori affezionati conoscono bene.