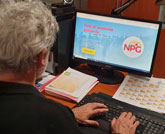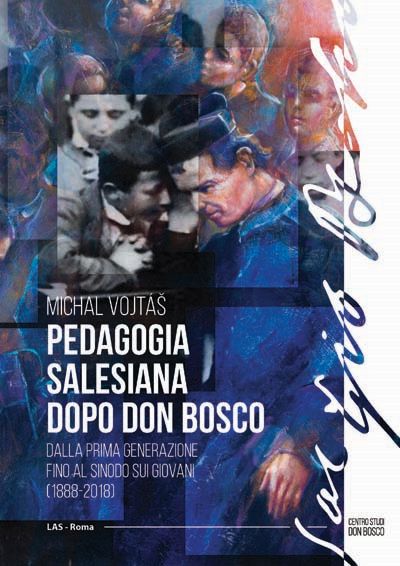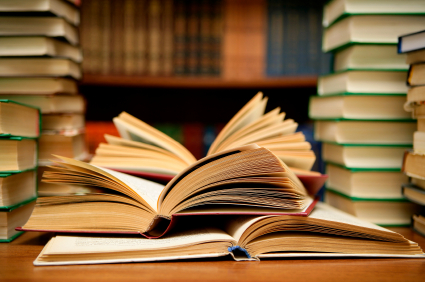Tavola rotonda
Cesare Bissoli – Mario Pollo – Riccardo Tonelli
(NPG 2004-03-7)
Domanda. Partiamo da una impressione diffusa: non si vedono più tanti giovani preti, usciti dai seminari dopo l’ordinazione o nei primi anni di ministero, bazzicare coi giovani, soprattutto nelle strutture educative usuali (oratori, scuole, gruppi educativi o attività di tempo libero ed estive), ma talvolta anche nelle attività più specificamente catechistiche che comprendano qualcosa più di un incontro di preparazione ai sacramenti.
Anche il gruppo di lavoro sul tema all’incontro nazionale di Palermo del 2002 parlava di “crescente difficoltà da parte del clero giovane al coinvolgimento nella pastorale giovanile”.
Certo, la situazione non è così netta, e ci sono tante eccezioni, sia in termine di presenza che di coinvolgimento. Ma non sfugge comunque agli osservatori un certo distacco tra giovani e preti giovani.
Quale è la vostra impressione, l’uno come responsabile di PG diocesana e tutti come formatori delle giovani leve sacerdotali proprio nell’educazione e pastorale giovanile?
Pollo. Per me rispondere a questa domanda è allo stesso tempo facile e difficile. Facile perché la “notizia” della ritrosia da parte dei preti giovani ad occuparsi dei giovani da alcuni anni giunge con insistenza alle mie orecchie. Difficile perché non so se questa notizia sia attendibile visto che è raccolta da osservatori che non possono essere definiti oggettivi o imparziali e, soprattutto, che non costituiscono un campione rappresentativo. Questa seconda considerazione mi fa sospettare che dietro la diagnosi del disinteresse dei giovani preti per la pastorale giovanile e la catechesi possa nascondersi uno stereotipo che, come è noto, influenza direttamente la nostra percezione della realtà.
Fatta questa precisazione, posso dire il motivo che più frequentemente ho raccolto (tra quelli indicati per spiegare questo fenomeno) è quello della predilezione dei giovani sacerdoti per le attività cultuali e la gestione formale del ruolo sacerdotale. Certamente l’attività con i giovani non si confà pienamente a queste preferenze.
Bissoli. Una diocesi come quella di Roma è un osservatorio che, con il pregio della concretezza, porta con sé anche il limite dell’esperienza, da confrontare quindi con quella di altri luoghi e persone.
In linea di principio condivido anch’io l’impressione di questo distacco (disinteresse, incapacità, autocentramento, spiritualismo, paura…?) tra preti giovani e giovani, anche se dispiace che non vi sia ancora in Italia una ricerca sull’argomento proprio fra giovani preti. È un segno anche questo di superficialità (a parte i soliti ostacoli clericali)?
Ma qui occorre fare delle precisazioni.
Quando si dice preti giovani bisogna intendersi. A Roma la media non è così giovane come sembra. Anzi, cresce il numero di adulti che si fanno preti (dunque sui e oltre i trent’anni). Mi domando se questi non sono abbastanza preti-giovani, o se non hanno mai imparato ad esserlo, perché non lo sono mai stati. Pensando a me “prete giovane” mi ritrovo, pur da seminarista ventenne, in mezzo ai giovani e con quale entusiasmo, “ragazzo quasi con i ragazzi”, ma sapevo tutto di loro.
Quando poi si dice giovani oggi, bisogna intendersi. Molti preti-giovani si trovano bene con giovani dai 18 anni in su, assai meno bene con gli attuali adolescenti (13-17 anni). Si può dire che anche nella Chiesa di Roma questi sono i più trascurati. Una certa ripresa di rapporto vi è con i bambini, che cala man mano che diventano adolescenti. Probabilmente è perché gli adolescenti di oggi sono difficili in tutti i sensi, veri nomadi, pur in piccoli spazi, a gruppi rinchiusi.
Devo tuttavia riconoscere che a Roma la maggior parte dei preti si prende a carico i giovani, alcuni in misura addirittura brillante, la maggior parte con gli incerti della frattura denunciata sopra.
Domanda. C’è certamente varietà di situazione e nessuna è così chiara e definita. Ma tornando al problema di quella percezione di distacco (notata anche nelle testimonianze di vari preti e degli stessi giovani, riportate nel numero precedente di NPG), c’è una qualche ragione particolare che potrebbe essere indicata come particolarmente significativa di questa non immediata sintonia o difficoltà?
Pollo. Dai racconti che ho raccolto intorno a questa situazione ho elaborato l’ipotesi che, dietro la fuga dal mondo giovanile e la contemporanea predilezione degli aspetti cultuali del ruolo sacerdotale, vi sia una profonda insicurezza personale. Confrontarsi con i giovani, specialmente se si ha un’età vicina o addirittura uguale alla loro, è molto rischioso se non si possiede una maturità umana solida. Il culto, e comunque il ruolo formale, offre invece un profondo sostegno, perché contiene le ansietà e le insicurezze personali.
È chiaro che questa ipotesi ha valore generale solo se le osservazioni del fenomeno sono attendibili. Nonostante questo, ritengo però che essa sia comunque valida per quei casi particolari che attuano la fuga dal mondo giovanile per rifugiarsi nel ruolo cultuale. Sarebbe comunque interessante poter fare una ricerca per validare questa ipotesi.
Se l’ipotesi fosse provata, essa indicherebbe che la formazione dei nuovi sacerdoti non cura in modo adeguato la maturazione personale, perché è orientata prevalentemente alla formazione professionale, culturale e teologica dei giovani preti.
Bissoli. Ce lo siamo chiesti di recente noi responsabili del Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile di Roma. Ecco i risultai del dialogo che espongo con fedeltà.
– I preti-giovani sono stufi di essere etichettati come incapaci, indolenti e non affidabili, per quanto riguarda la PG. Vi è una certa mitizzazione di sfiducia nei loro riguardi di cui sono a conoscenza, ed essi reagiscono con ulteriore senso di frustrazione e chiusura. Va detto – ed è molto importante – che tale giudizio riguarda non solo la relazione prete-giovane e giovani, ma il prete-giovane tout court nel complesso delle attività parrocchiali, o estraneo, o impacciato, o schiacciato. Ovviamente non in termini assoluti e secondo me, a Roma, nemmeno in termini di maggioranza, ma probabilmente come linea di tendenza che cresce.
– I preti-giovani non sono preparati ad andare con i giovani (e tanto meno con i lontani o con quanti si allontanano: manca una spiritualità giovanile missionaria!), come saperci stare, da preti educatori. Non sanno come si fa accompagnamento e prima ancora perché farlo.
Lo si dà per scontato, come forse nel passato si poteva fare. Per cui né sono invogliati a farlo, né, una volta entrati in contatto con i giovani, mostrano capacità di pastorale giovanile.
– Gli esiti sono: il restringimento al gruppo sempre più piccolo (a Roma si prevede che, fra non molto, non poche parrocchie non avranno nemmeno un gruppo giovanile, di adolescenti e giovani, mentre continuerà quello dei bambini della prima comunione), o abbandono, o tuffo (ma è di pochi) in attività sociali e ludiche.
Un tratto inquietante, segno di impreparazione, ma anche di sotterraneo compenso, è la costruzione della PG sulla persona dell’animatore, andando via il quale (cosa che avviene per normale avvicendamento), la PG cade e il successore deve cominciare tutto da capo.
Un altro segno è l’eccessivo dispendio di tempo del prete con un solo giovane o il piccolo gruppo, fino a tarda ora della notte, dimenticando gli altri impegni, anche di salute.
Un altro esito piuttosto frequente è l’abbandono dello stesso sacerdozio, magari incentivato da una ragazza (e per di più non sempre bella). Ma questo è effetto più che causa diretta.
– Vuol dire mancanza di fede? Certamente il servizio ai giovani, e più largamente alle persone, sembra talora che non sia inculcato come semplicemente il modo di essere preti. Non si sa di quale apostolato sono stati informati e formati. Vuol dire carenza di una proposta diocesana di PG? In realtà viene offerta, ma tra centro del Vicariato e chiesa del territorio vi è grande distanza e non comunicazione.
– Scarsa è la proposta cristiana larga, aperta, sul mondo delle sofferenze altrui, dunque sul volontariato e sulle missioni. Segno di una PG asfittica. Ma ci chiediamo, alla fine, se questa generazione di preti-giovani non corrisponda alle fragilità proprie dei giovani cui sono mandati.
Domanda. Alcune testimonianze rilevano il rischio di considerare la PG proprietà privata, terreno di caccia per i giovani preti, in nome di una presunta affinità o perlomeno vicinanza di età.
Ma la PG non è per definizione compito di tutta la comunità ecclesiale, di ogni sua componente, e allora il rifiuto del prete giovane di sentirsi destinato alla fetta dei giovani richiama un problema di chiesa?
Pollo. Al di là dei motivi per cui i giovani preti non gradiscono prendersi cura dei giovani, resta la constatazione che da molti anni questa cura è stata delegata quasi interamente allo stesso mondo giovanile, di cui i preti giovani fanno naturalmente parte. Ci sono, infatti, giovani che educano giovani, sia come educatori, animatori e catechisti, o addirittura adolescenti che hanno responsabilità educative nei confronti di loro coetanei.
Questo è indubbiamente il segno di una ritirata degli adulti dalla responsabilità educativa, e non solo, nei confronti delle nuove generazioni e del corrispondente isolamento relazionale delle generazioni.
La pastorale giovanile richiede invece che si rompa l’isolamento generazionale e si riattivi la comunicazione intergenerazionale, che è la sola che può produrre una comunità cristiana autenticamente educante e capace di iniziare in modo non debole le nuove generazioni alla appartenenza ecclesiale e alla vita cristiana.
Bissoli. La PG a Roma viene attribuita per tradizione al giovane prete appena ordinato, nella supposizione che egli agisca nel contesto della parrocchia. Ma qui – come è stato denunciato dai responsabili del nostro Servizio – prevale spesso un laissez faire dei parroci, che equivale ad un abbandono, con le implicanze di una autonomia del prete animatore fino alla separatezza con i pochi giovani raccoglibili o alla pratica di un lavoro minimale burocratico subito e che non piace
Di converso è stato riscontrato che il prete giovane si vede chiusa la porta a fare altri servizi parrocchiali (tipo battesimo, o messa parrocchiale) per fare – questo sì – tanti e tanti funerali.
Non nascondiamoci, mi sembra ovvio, che per stare oggi da giovani preti con i giovani occorre ripensare radicalmente, sia la realtà di chiesa, sia di cammino di fede, sia di stile tradizionale di rapportarsi a loro. Come può il giovane prete andare dove i giovani vivono (e fanno la canna o altro) nello standard parrocchiale attuale?
Tonelli. Riprendo l’insieme di queste prime domande e vorrei collegarle in una risposta articolata.
La tradizione pastorale da cui vengono molti di noi, gente dai capelli ormai bianchi e con qualche anno sulle spalle, tendeva ad affidare ai preti appena sfornati dal seminario o dalle istituzioni formative l’azione diretta verso i giovani e la gestione delle strutture specializzate per essi (gli “oratori”, nell’espressione tradizionale). Sembrava ci fosse una consonanza tanto naturale che era logico impegnare i giovani preti nell’azione pastorale con i giovani e lasciare ai preti più navigati le responsabilità più alte.
Le ragioni addotte erano moltissime: chi è giovane se la vede meglio con i giovani, chi è giovane sa stare più facilmente al ritmo dei giovani, chi è giovane avrà tempo per crescere e per maturare e allora si prenderà le responsabilità più impegnative, e cose del genere.
Serpeggiava però anche un altro modello, di una lega peggiore. È capitato a me. Avevo finito i miei studi e il mio superiore ha fatto l’errore istituzionale di lasciarmi scegliere tra un impegno di docenza e il lavoro diretto con i giovani in oratorio. Io ho scelto l’oratorio. Molti miei confratelli – quelli appartenenti alla categoria dei saggi – si sono meravigliati ampiamente: tanto studiare… per finire nel cortile di un oratorio.
Oggi questo modo di fare è in crisi per due ragioni contrapposte. Una la considero davvero preoccupante e l’altra invece particolarmente sapiente.
Incomincio da quella preoccupante.
Ho l’impressione che molti giovani preti non siano entusiasti di finire in un lavoro pastorale tra i giovani, soprattutto se questi giovani sono “tutti” i giovani e non quelli bravi, che riempiono di consolazione il cuore e la mente – sofferente di solitudine – dei preti. Ci si sente un poco abbassati di tono se la responsabilità che viene affidata è un poco generica (il “prete da oratorio”, come si dice), senza grosse prospettive davanti. L’unica consolazione è quella della durata: si tratta di un incarico breve, a termine, tanto per incominciare e farsi un poco le ossa; dopo le cose cambiano… e cambiano in meglio. Qualcuno persino parla di prova, per fare bella mostra delle proprie capacità. E poi – si dice – ci vuole il fisico adatto e interessi giovanili adeguati.
L’altra ragione, quella che valuto sapiente, vede le cose da un’ottica molto diversa.
La pastorale giovanile è una faccenda seria. Richiede preparazione, coraggio, fedeltà capace di andare oltre le prove. Non può essere affidata al primo venuto. Ci si potrebbe bruciare le penne. E così, chi è responsabile stenta a dare compiti; chi li deve assumere fa di tutto per scaricarli su altri.
Questi sono i “fatti”, impressioni che diventano constatazioni quando sono documentati con cifre e riferimenti verificabili. E non è certo questo il mio caso, qui.
Mi si chiede una reazione, dichiarando, in qualche modo, come la vedo io.
A monte sta un modo di pensare alle responsabilità pastorali (quelle verso i giovani non sono diverse dalle altre) e, più radicalmente, una verifica del cammino formativo.
Incomincio dalla faccenda più seria.
La pastorale giovanile – a tutti i livelli – ha come soggetto titolare la comunità ecclesiale nel suo insieme. Nessuno può delegare ad altri qualcosa che compete invece a tutti. La responsabilità di portare a pienezza di vita e a speranza consolidata i figli che sono stati generati non si può scaricare su nessuno: né giovane, né anziano. La titolarità è piena e complessiva. Certo, può essere realizzata in modo operativo da qualcuno. Egli agisce però a nome di tutti, per rappresentare tutta la comunità, e non solo per dare conto alla comunità degli eventuali errori che fanno saltare la mosca al naso alla parte saggia della comunità.
Non è questione, né di giovani, né di anziani, ma di una responsabilità che qualcuno realizza in riferimento di tutti.
Una seconda ragione può giustificare la paura che alcuni giovani preti manifestano, quando sono richiesti di realizzare un servizio privilegiato verso i giovani.
Abbiamo bisogno di testimoni: i giovani prima di tutto. Il testimone condivide pienamente l’esistenza comune, ma sa manifestare una qualità di vita e di fede che lascia il segno e fa sorgere le domande centrali dell’esistenza. Non bastano pochi anni in più sulle spalle, per esercitare questa funzione educativa, provocatoria e propositiva nello stesso tempo. Oggi ci sentiamo premuti dai nostri limiti e le incertezze esistenziali minacciano la capacità testimoniale, e non vogliamo certamente finire in una testimonianza che nasconde limiti e incertezze per risultare più convincente.
In fondo, noi adulti abbiamo imparato bene a fare la faccia di circostanza quando c’è bisogno. I giovani – per fortuna – non hanno in riserva le facce per le diverse stagioni.
La terza ragione merita una riflessione più lunga. La pastorale giovanile è un compito impegnativo e tutt’altro che facile. Si richiede preparazione, sensibilità, competenza alle spalle, capacità di rischio e fiducia, una dose alta di speranza e una esperienza profonda di fede.
Mi chiedo se i processi formativi tradizionali abilitano personalità così. E ho una certa perplessità a trascrivere una risposta affermativa, sicura e perentoria.
Chi preferisce non rischiare sta mettendo sotto discussione la formazione ricevuta.
Una quarta ragione non posso tacere. Ho paura che la prevalenza di modelli formativi eccessivamente spiritualisti, che disdegnano il lavoro di routine quotidiana e la fatica di una condivisione, accogliente e gratuita, nel nome altisonante della propria vocazione, introduca una strana gerarchia di compiti e di missioni. Chi è saggio… sceglie quelle di prestigio e di livello più alto.
A questo proposito, ci vuol poco a constatare come ci stiamo muovendo – nella chiesa italiana e non solo – nella logica del pendolo. Facciamo come il pendolo: oscilliamo tutti da una parte, per qualche battuta di tempo, pronti ad oscillare dall’altra… sapendo che, presto o tardi, l’aria cambia e torna in auge la logica precedente.
L’operazione è pericolosa: va in crisi la completezza delle prospettive e la complementarità delle posizioni. E poi ci sono sempre i furbi che aspettano, senza scomporsi, il ritorno dell’oscillazione nelle loro posizioni.
Fuori metafora, dico a cosa alludo e cosa mi preoccupa.
La stagione precedente il Concilio era tutta segnata da mille impegni, di quelli che oggi chiamiamo “di supplenza”. Si trattava di presenze piene e attive nel ritmo della vita e degli interessi quotidiani dei giovani, senza eccessiva discriminazione elitaria.
Poi, le nuove sensibilità conciliari hanno aiutato a scoprire cosa va fatto in prima persona e cosa va affidato alla corresponsabilità di altri. Soprattutto la riscoperta della centralità dell’evangelizzazione, della forza della Parola di Dio e delle attività che, in qualche modo, ne fanno sapiente contorno, ha messo in crisi molte attività tradizionali. Oratori, scuole e gruppi di interesse sportivo, culturale, di tempo libero sono stati guardati con sguardo critico. Qualcuno li ha svenduti al primo acquirente, per impegnare tempi e risorse su quello che conta di più.
Alla prova dei fatti, molti si sono resi conto di quanto la decisione fosse poco saggia, se veniva perseguita con la forza dell’entusiasmo adolescenziale. E così si è tentata la rioccupazione degli spazi vuoti. I poveri… giovani preti si sono trovati a gestire cose per le quali non erano stati preparati. Basta pensare alla stagione dell’impegno politico e dell’attività sul territorio.
Oggi il pendolo gira dall’altra parte, verso una visione e azione pastorale molto più spiritualista, d’élite, abbastanza disincarnata.
E domani?
Domanda. E allora, cosa si aspettano i giovani da chi li vuole seguire nel loro cammino umano e di fede, e cosa si aspettano i preti giovani da questo cammino comune? Le reciproche attese possono entrare in sintonia e condivisione?
Bissoli. I giovani sono più potenza che atto. Quindi, invece che voler sapere cosa si aspettino i giovani di oggi, importa ripensare ciò di cui i giovani hanno bisogno, più di quando di fatto domandino.
Essi hanno anzitutto bisogno di persone che si interessino personalmente di loro, senza pretendere che il giovane si interessi del prete (almeno non all’inizio). Di qui la necessità di rendersi capaci di incontrarli dove vivono e farsi accettare da loro
Una volta contattati, si aspettano un adulto che faccia sovente il supplemento (non per sé il sostituto) di papà e mamma. Un grande che si china per far crescere. Verità e bontà, testimonianza e pazienza…
Per la proposta della fede, che non è per sé rifiutata, si richiede un tempo di maturazione e di esperienza, mantenendo la fedeltà a Gesù Cristo nella sua Chiesa, ma anche pedagogicamente tenendo presente le debolezze del giovane, specialmente in ambito sessuale.
Infine, ecco una serie di bisogni giovanili oggettivi, anche se non avvertiti: educare all’amore, educare alla preghiera, educare alla carità, fare orientamento vocazionale, aprire frontiere sociali e missionarie.
Tonelli. Non è facile dire cosa i giovani si aspettano dai giovani preti, soprattutto quando alle frasi ad effetto si preferiscono quelle meditate e motivate.
Le difficoltà sono due: i soggetti e la verifica delle attese.
Parto da una constatazione… che non mi trova per nulla entusiasta.
Ogni tanto, quando si organizzano convegni o si valutano quelli realizzati, nell’ambito della pastorale giovanile, spunta il suggerimento: dobbiamo far parlare i giovani. E così dieci giovani sono invitati a dire la loro e molti relatori girano la loro riflessione sulle battute più interessanti di questa rassegna di testimonianze.
Chi sono e cosa rappresentano i dieci che hanno dato testimonianza?
L’universo giovanile è variegato all’inverosimile. Non lo possono rappresentare le statistiche, quelle che attribuiscono al 20.5% una cosa e al 57.7% un’altra. Non lo possono certo rappresentare dieci voci scelte comunque a caso.
E poi, se c’è un mondo manipolabile, è quello delle attese. Le prime battute sono manifestazione della cultura dominante nel gruppo di riferimento, o rappresentano la possibilità di far esplodere finalmente quello che bolle in pentola… o sono la voce ponderata di un gruppo ristretto…
Certo, non vale il contrario: la prassi di chi dice: “io i giovani li conosco e non ho bisogno di farli parlare per sapere quello che vogliono!”, merita solo compassione.
Sul piano del metodo, sono convinto che dovremmo interpretare dal profondo dichiarazioni e risultati delle ricerche, per leggere tra le righe e generalizzare con moltissima cautela.
Sul piano del contenuto: cosa vogliono i giovani?
Ogni risposta è sempre un poco autobiografica.
Ho l’impressione che ci sia una diffusa e pervasiva crisi di speranza. Abbiamo scoperto il bisogno di vita e di felicità, e siamo diventati critici nei confronti di tutti coloro che ce la promettano, a caro prezzo o in liquidazione. Resta però l’attesa, espressa in mille modalità, qualche volta tanto disturbate da sembrare indicare direzioni contrarie.
Chi vuole speranza, cerca qualcuno che gliela faccia toccare con mano. E cerca un fondamento sicuro alla speranza: non è speranza quella che brilla solo in qualche momento e si riperde presto nel buio e nel silenzio.
I giovani preti, formati ad essere giovani di speranza, possono diventare narratori di speranza, capaci di spostare il riferimento dalla loro persona all’unico nome che può darci vita e speranza.
Domanda. Nell’analisi di questi problemi si chiama sempre in causa la formazione, e dunque i seminari. Ovviamente la formazione non è i seminari, ma tutto un insieme di appartenenze, apprendimenti, esperienze, relazioni... Se questo discorso è corretto, come arriva il seminarista in seminario? E come giudica la formazione dei giovani preti, sia come persone che come pastori? Dunque, difetti e pregi della formazione sacerdotale oggi.
Pollo. Non sono in grado di entrare nel merito della formazione dei giovani sacerdoti, se non ribadire il sospetto, già indicato prima, che essa sia in alcuni casi carente dal punto di vista della maturazione umana. A questo aggiungerei che, forse, a monte della formazione non vi è, in molti casi, una selezione e un orientamento dei giovani aspiranti preti adeguata.
Bissoli. Questa della formazione in seminario è un vero punctum dolens, senza però voler indicare il seminario come capro espiatorio. Occorre attendersi dal seminario (che oggi a Roma è solo più il Seminario maggiore) ciò che può dare. Piuttosto è compito della Chiesa locale (vescovi, parroci, comunità) fare da seminario, in stretta cooperazione con quello in senso stretto, ma non in senso unico.
A Roma si constata, oltreché la non facile flessibilità delle vocazioni adulte, l’impreparazione teologica (= catechismo!) dei candidati, incertezza di motivazioni, spinte spiritualistiche più che pastorali, fragilità affettive.
A Roma la formazione è ancora legata alle Università Romane, che occupano tempo per lo studio. Ma soprattutto nel seminario sembra che manchi un contatto formativo (non ricreativo o culturale) con la Chiesa reale.
Vi è per sé una esperienza pastorale nei tempi stabiliti, ma pare che non diventi scuola formativa con la guida di competenti che verificano, né in seminario, né nelle parrocchie dove vanno, in quanto tra parrocchie e seminario non vi è una operazione sinergica, programmata.
E d’altra parte è stata notata tanta generosità di diversi seminaristi a fare un servizio con i giovani e lo stanno facendo bene.
La componente pedagogica giovanile (come essere educatori dei giovani oggi, ed esserlo da cristiani, da pastori) pare essere tema marginale in seminario, per mancato dialogo fra teoria ed esperienza, sempre sulla supposizione che si sa fare a sufficienza o si impara presto. L’oratorio come formula è praticamente ignorato. Un possibile associazionismo giovanile è trascurato.
E d’altra parte – cosa accertata – avviene che, quando il giovane prete entra in parrocchia, si tronca ogni legame con il rettore o padre spirituale del seminario, sì da essere solo in parrocchia e solo riguardo al seminario.
Insomma, si vuole un prete che stia con i giovani e non vi sono persone che stiano con questo giovane (prete).
Per cui non diventa mentalità, per un giovane seminarista, che fare il prete domani non è tanto dire messa o fare conferenze, ma incontrare persone con le quali e per le quali dire Messa. A mio parere, la carità pastorale, come componente costitutiva del ministero del prete, è troppo ai margini.
Tonelli. Oggi assistiamo ad una diffusa e pericolosa crisi formativa. Riguarda due ambiti, complementari. Il primo è quello dei contenuti del processo formativo. Il secondo riguarda la modalità di realizzazione.
I nostri centri formativi sono transitati da una stagione giocata all’insegna della abilitazione al praticone, esperto nel fare le cose di campo operativo e poco propenso a fermarsi a pensare e a studiare, con la scusa che ci sono i centri specializzati per questo, ad una formazione specializzatissima sul piano formale, che dà informazioni ma non abilita sempre a costruirsele, che si misura su quello che si conosce o si ignora, e poco invece sull’arte e la competenza metodologica.
I modelli e le valutazioni sono spesso orientati verso sistemi di valori che hanno poco da spartire con chi si dovrà trovare alle prese con i problemi quotidiani che l’azione pastorale con i giovani richiede.
La seconda ragione di crisi è data dal ritmo. Non mancano responsabili formativi che proclamano la logica del “prima studia, poi opererai”. Per operare avrai tutta la vita davanti. Per studiare, il tempo finisce presto. Chi proprio ci tiene e lo vuole, troverà nel tempo libero lo spazio per sperimentare, ma poi nel tempo occupato la verifica, l’interpretazione e la riprogettazione ha poca o nessuna risonanza.
E se invece distinguessimo tra acquisizione di informazioni e abilitazione a competenze per dire che cosa è formazione? E se immaginassimo un ritmo formativo che sappia dare al vissuto, all’esperienza, una precisa valenza formativa, alla condizione di farla attento oggetto di verifica e di previsioni operative?
Certo, i pareri sono diversi. Sono convinto che siano proprio queste diverse pratiche risposte che determinano una certa disaffezione di molti giovani preti nei confronti dell’azione diretta con i giovani.
Se la disaffezione è virtù, basta consolidarla. Se è disfunzione, andrà programmata la terapia adeguata, che non è certo quella delle raccomandazioni e dei buoni consigli.
Qui sta, secondo me, uno dei nodi del problema.
Lo si ripete spesso: siamo in crisi di formazione; per affrontare in modo serio i problemi che attraversano questo nostro tempo, ci vuole maggiore formazione; chi investe risorse sulla formazione, investe sul futuro. Constatazioni verissime e urgenti.
Una condizione però resta pregiudiziale: quale formazione?
Da molte parti, l’attenzione corre soprattutto sui contenuti da conoscere e da assimilare, come se la formazione si potesse misurare sulle informazioni assimilate. Qualche altro mette in gioco le competenze da acquisire e le manifestazioni esteriori di queste competenze.
La mia convinzione è un poco diversa. Credo che il problema sia – per i giovani preti e per tutti noi – di un modello di formazione.
Penso alla formazione come a quel processo orientato alla stabilizzazione della personalità attorno ad un quadro di significati fondamentali, che funzionino come senso e orientamento. In una stagione di pluralismo e di complessificazione, abbiamo bisogno tutti di ricostruirci questo quadro unitario centrale di senso, che sia capace di farci valutare l’esistente e ci inquieti continuamente per la sua trasformazione. Per i sacerdoti in formazione, giovani coraggiosi, con una decisione di fondo che riscrive tutta la vita, questo quadro fondamentale è la passione per la vita di tutti nel nome di Gesù.
Mi sembra di fortissima attualità la criteriologia proposta da Pietro per scegliere il successore di Giuda: una persona capace di fare di Gesù l’unico signore della propria vita, lottando contro tutti gli idoli nel suo nome; una persona capace di narrare speranza con la sua vita, nel fede del crocifisso risorto.
Fare formazione significa abilitare le persone a giocare tutta la propria esistenza attorno a questa causa appassionante e a tradurre l’orientamento di fondo nei piccoli concreti gesti della propria qualifica professionale.
Ho l’impressione che da questa prospettiva molte preoccupazioni formative dominanti possano essere ridimensionate, e molte rimandate ai tempi successivi balzino decisamente in primo piano.
Certo, si tratta di un processo e non di una conquista una volta per sempre. I responsabili valuteranno se l’orientamento di vita sta muovendosi nella logica del processo o se invece non diventa urgente una coraggiosa inversione di rotta.
Domanda. Una delle difficoltà legate alla formazione è certamente la poca chiarezza rispetto al profilo e competenze di chi si prende cura dei giovani. Quali sono, sia in termini generici che realisticamente parlando?
Pollo. Indubbiamente, la competenza necessaria per poter prendersi cura dei giovani è genericamente quella educativa. Questa competenza si fonda, a livello minimo, sulla conoscenza della realtà giovanile, sulla conoscenza dei percorsi di crescita e delle caratteristiche che sono tipiche delle varie età giovanili, sulla conoscenza dell’educativo, ovvero delle proposte intorno all’umano della pedagogia, sulla conoscenza della pastorale giovanile e, infine, su un’autentica competenza relazionale. Quest’ultima competenza appare strategica, non solo ai fini dell’azione con i giovani, ma in generale con tutte le persone. Per questo motivo, essa dovrebbe essere un elemento costitutivo della formazione dei sacerdoti. Tuttavia, l’acquisizione di questa competenza non è facile, perché essa richiede, non solo l’acquisizione di alcuni metodi o di alcune tecniche, ma una vera e propria trasformazione personale. Occorre infatti tenere conto che la capacità relazionale nasce da un percorso formato da almeno quattro passi.
Il primo passo è costituito dal riconoscimento e dall’accettazione, da parte della persona, della propria identità personale e, quindi, del proprio progetto personale di vita. Occorre chiarire che questo riconoscimento e questa accettazione dell’identità personale non si esaurisce nella presa di coscienza del proprio corpo, della propria psiche e delle proprie condizioni economiche e sociali. Infatti, essa richiede che la persona scopra il senso e il significato che conferisce alla realtà e che dipende dal modo in cui assume la propria esistenza.
In altre parole, il riconoscimento e l’accettazione di sé dipendono dal senso che si dà al proprio corpo, alla propria psiche e alla realtà socio-economica che si abita.
L’identico corpo, l’identica psiche e le identiche condizioni socio-economiche possono dar vita a differenti progetti esistenziali, a seconda del senso che ad essi viene attribuito da chi li possiede.
La scoperta del proprio modo di interpretare la realtà e, conseguentemente, dell’assunzione cosciente e responsabile del proprio progetto di vita è un passaggio indispensabile nella costruzione della relazione autentica. Paradossalmente, questa scoperta viene favorita dalla sperimentazione della ricerca della relazione autentica.
Il secondo passo è dato dal riconoscimento e dall’accettazione dei limiti e delle possibilità che la realtà offre. In altre parole questo significa che la persona deve sviluppare una concezione realistica del mondo e della vita e, quindi, riformulare il proprio adattamento all’ambiente naturale e sociale in modo da poter esprimere il massimo di se stessa all’interno delle condizioni sociali, economiche, culturali e naturali in cui vive.
Il terzo passo viene sviluppato, invece, con il riconoscimento e con l’accettazione integrale degli altri e della loro identità e dei loro progetti di vita. Questo significa non solo la conquista della tolleranza, ma la capacità di capire gli altri, di interpretare cioè correttamente il loro modo di porsi nei confronti di se stessi, degli altri e del mondo. Questo esige uno sforzo di decentramento, un mettersi “nei panni” degli altri, cercando di capire il senso che questi danno della propria vita, di se stessi e delle proprie azioni.
Il quarto passo è la decisione a cooperare, ovvero a vivere un rapporto solidale, di mutuo aiuto, con gli altri al fine di favorire il proprio e l’altrui cambiamento verso una forma più autentica di vita. Questo significa che la comunicazione scopre, al di là del rapporto Io-Tu, quello del Noi. È questa indubbiamente la fase finale del cammino verso la costruzione di una comunicazione interpersonale autentica. Tuttavia, perché questa tappa sia raggiunta (come del resto anche le altre tre), è necessario che la persona, mentre compie il proprio cammino verso di essa, eviti tre comportamenti.
Il primo è costituito dall’evitare ogni giudizio di valore sull’altro. Dare un giudizio di valore significa infatti non accogliere l’altro nell’immediatezza e nella genuinità del suo vissuto, bensì in funzione del proprio personale sistema di valori, oltre che dei propri pregiudizi e immagini stereotipe della realtà.
Il secondo comportamento da evitare riguarda l’applicazione di etichette a sé e agli altri, magari sulla base di teorie psicologiche o di modelli culturali. Dire di una persona che è introversa significa che, invece di capire quella persona sulla base del suo comportamento concreto nel rapporto di comunicazione, si cercherà di osservare in quella persona i comportamenti e gli atteggiamenti che confermano l’etichetta che le si è data. Etichetta che fa sì che quella persona diventi simile a una moltitudine di altre persone e che le sue caratteristiche più particolari e uniche diventino praticamente invisibili. Lo stesso discorso vale anche nei confronti di se stessi. Darsi un’etichetta significa limitare la propria capacità di capire il proprio modo di essere e di dare senso alla vita.
Il terzo comportamento che occorre superare riguarda il considerare l’Io e il Tu che entrano in comunicazione come un accostamento più o meno accidentale di due entità separate. Occorre a questo proposito ricordare che l’Io e il Tu possono entrare in comunicazione solo perché esiste un Noi che viene prima dell’Io e del Tu. Se non esistesse un Noi (natura, società, cultura), non esisterebbe alcun Io e alcun Tu, perché l’uomo non maturerebbe la sua coscienza, la sua libertà e la sua autonomia personale. Il bambino conquista il suo Io e diventa uomo solo perché c’è un Noi che si prende cura di lui, lo nutre, lo educa, gli insegna il linguaggio e lo introduce in una data società e cultura sociale.
Tra gli uomini esiste un Noi che è sottostante al loro Io, anche se occorre sottolineare che è attraverso i rapporti Io-Tu che viene continuamente trasformato e ricostruito il Noi.
Come si vede, il raggiungimento della competenza relazionale richiede, sia un lavoro con gli altri, sia con se stessi.
Bissoli. Credo di aver risposto nelle domande precedenti. Penso che al giovane prete che incontrerà i giovani va detto che tale incontro non è una corvée, ma una grazia del suo sacerdozio. E quindi va inoculato l’amore per i giovani, la cosiddetta “passione”, come volontà certa di Dio. Come è della volontà di Dio sapere come ci si sta, i limiti, i pericoli… Quanto più si preme sul tasto del dover essere, tanto più occorre curare quello dell’essere, della realtà, dei piedi per terra.
Vi rientra il curricolo formativo sotto forma di un tirocinio di prova a tutti i livelli, di contenuto e di metodo: bisogna saper parlare ai giovani, conoscerne i gusti, magari rinunciando un po’ ai propri…, entro una progettualità teorica e un insieme di esperienze da fare, quali saper programmare un piano di formazione dei cresimandi, un campo scuola, un laboratorio…
Altri punti di interesse per la formazione sono: come suscitare e formare animatori laici e come si collabora con loro; come si incontrano le famiglie dei giovani; come farsi angeli custodi di randagi e perduti, come operare un confronto valutativo sulla propria pastorale giovanile.
Domanda. In tema di carismi e ministeri (sia quello sacerdotale che quello di educatore-animatore, soprattutto dei ragazzi e giovani), è sempre bello entrare nella prospettiva dello scambio reciproco di doni. Cosa dà il sacerdozio all’educatore e l’educazione al sacerdote? Oppure, in termini più concreti, cosa danno i preti ai giovani e i giovani ai preti?
Pollo. Credo che l’educatore offra al prete la concreta esperienza del costruirsi attraverso la relazione con e per l’altro; l’esperienza del dono per il proprio sé, che è contenuto in ogni esperienza di alterità. L’esperienza che la propria crescita personale è legata al sostegno dato alla crescita dell’altro e alla disponibilità a ricevere ciò che l’altro ha da offrirci all’interno di una relazione di autenticità.
In particolare, per quanto riguarda la relazione con i giovani, in essa non vi è solo il dono che il passato fa al futuro. Un dono che, se rifiutato, provoca l’inaridimento della vita e non consente all’educazione e alla socializzazione di svolgere la loro funzione di motore della civiltà. Ma vi è anche il dono che i giovani fanno del futuro al presente di chi educa, aprendolo a ciò che è oltre la sua mortalità.
L’educatore conquista la sua adultità educando, aiutando i giovani a vivere integralmente la propria giovinezza. Alla base di questa affermazione c‘è la convinzione che, come ha chiarito la moderna ricerca psicologica, sociologica e antropologica, l’età adulta è una età in cui la persona prosegue il suo ciclo evolutivo, anche se in modo meno evidente. La condizione adulta è la fase in cui la persona deve far evolvere la “differenza”, conquistata nella fase evolutiva precedente, verso l’unità e la totalità.
Essa è anche la fase in cui la persona deve restituire, a livello sociale, i frutti della sua evoluzione personale, e deve quindi ricambiare i doni ricevuti nel corso del suo processo di formazione personale.
Infatti, l’adulto ha costruito la sua individualità originale, il suo Io, solo perché è esistito un Noi che gli ha fornito l’aiuto necessario al suo farsi uomo, al suo costruirsi.
Come si è già sottolineato, senza questo Noi, che è l’espressione della solidarietà concreta di un gruppo sociale, così come viene vissuta direttamente dall’uomo nelle sue fasi evolutive che vanno dall’infanzia all’adolescenza, nessuna persona raggiungerebbe l’autonomia e la responsabilità tipiche dell’essere autocosciente. Il Noi, ovvero la cura che ogni uomo manifesta per gli altri uomini che condividono con lui lo spazio tempo sociale, è una sorta di prestito che ogni persona, una volta divenuta adulta, deve restituire, con gli interessi, alle nuove generazioni, divenendo per esse una espressione concreta dello stesso Noi.
L’educazione, specialmente se svolta utilizzando il modello dell’animazione, offre al prete l’occasione e gli strumenti necessari a generare l’evoluzione del suo essere adulto, consentendogli di operare quella restituzione, senza la quale non può pretendere di partecipare solidarmente al Noi.
In quest’ultima affermazione è implicita la risposta all’ultima domanda. Infatti l’educatore di cui a mio avviso questi giovani hanno bisogno è l’animatore culturale. Sottolineando che l’animatore è colui che crede profondamente che la possibilità di ogni persona umana di costruirsi secondo un progetto richiede la solidarietà attiva di un gruppo di persone. L’animatore cioè sa, come dice Paulo Freire, che “ci si educa tutti insieme”, che la costruzione di se stessi è un fatto che coinvolge la responsabilità delle persone con cui si vive, anche se l’ultima parola spetta solo al singolo individuo.
Allo stesso modo, l’animatore, essendo consapevole della bidirezionalità della comunicazione educativa, sa che essa ha effetti su di lui, oltre che sugli educandi. Egli sa cioè che le azioni educative che egli intraprende si riverberano sulla sua esistenza, modificandola.
Infine, ciò che contraddistingue l’animatore è la profonda capacità di credere alla persona di ogni uomo, perché la persona è il suo grande assoluto. Egli sa che la persona rischia di essere sopraffatta dalla trama intricata delle relazioni politiche, economiche e culturali. Tuttavia, egli si gioca nella scommessa che, attraverso l’educazione, è possibile far crescere e sviluppare le forze che possono rigenerare l’uomo e la società in cui vive e, quindi, agire in senso preventivo.
In questo senso, l’educatore/animatore è uno che crede in un progetto di liberazione dell’uomo di cui si pone al servizio, è un militante della causa dell’uomo. Ma la sua disponibilità a giocarsi nell’interazione con queste motivazioni non è sufficiente a garantirgli il realizzarsi del processo educativo. È necessario che egli gestisca la relazione con “competenza tecnica”, se non vuole diventare una sorta di apprendista stregone, il cui entusiasmo genera più guai che cose utili. Viceversa, la competenza tecnica, priva di adeguate motivazioni, produce un freddo e impersonale processo burocratico, che, invece di seminare la vita, distribuisce i conservanti utili alla sua ibernazione.
È solo la competenza tecnica, sposata alle motivazioni, che può generare quella comunicazione esistenzialmente significativa che fonda il modello educativo dell’animazione.
Bissoli. Questo è un bel capitolo da sviluppare, magari ascoltando coloro che erano giovani (preti e laici) e che sono giovani oggi (preti e giovani).
Ritengo, alla luce di quanto detto prima, che il prete può donare al giovane la gioia di trovare una paternità limpida, una testimonianza generosa e leale, un amico di cui puoi fidarti oggi e soprattutto domani, quando si ritorna magari alla pratica religiosa, e che in ogni caso porti nel ricordo come una figura gradita.
Una cosa non gradisce il giovane dal suo prete: l’aridità del cuore, la durezza, l’incapacità di perdonare, l’insincerità e l’infedeltà, il doppio gioco, l’incoerenza, la cattiva testimonianza nella preghiera e nella castità.
Il giovane può donare al prete la gioia di amare una persona e di essere amato, alla Don Bosco per intenderci, insomma di sentirsi padre di tanti figli. Una vera gioia di vivere, per cui alla sera si attende che arrivi il giorno dopo per incontrarli ancora. Se i giovani non fanno “sognare” nuove iniziative, nuovo dono di sé, nuova offerta di sacrifici, qualcosa non va.
Il giovane dona al prete la grazia di trovare vocazioni. Il giovane dona al prete di farsi santo nella fedeltà e nella pazienza.
Ovviamente, entro questa relazione alta, vi sono poi i cambi e prestiti reciproci, il giorno per giorno
Chiaramente, entro questo quadro di rapporti non ci metto Gesù Cristo, perché ci sta già dentro tutto, altrimenti non sarebbe possibile resistere.
Tonelli. La domanda sullo scambio reciproco di doni, nella vita quotidiana e nella fede, mi trova particolarmente sensibile.
Lo valuto una esigenza difficile da praticare, ma fondamentale per crescere.
Oggi si parla spesso di identità. È normale constatare lo stato di diffusa crisi che l’attraversa. Si moltiplicano di conseguenza le raccomandazioni sul suo consolidamento, sulla sua stabilizzazione, sulla sicurezza che dovrebbe possedere.
Molte delle battute precedenti fanno intravedere dove corra la mia preoccupazione.
Non posso non condividere l’urgenza della questione dell’identità, soprattutto in una stagione dalle mistificazioni facili.
Penso però all’identità come all’esito di un processo di scambi reciproci: con il mistero di se stesso, degli altri, dei compiti, della trama del quotidiano… spazi tutti dove lo Spirito continua a farsi voce per noi.
Lo scambio è possibile se ho qualcosa da scambiare e se sono felice di incontrarmi con persone che hanno cose diverse da scambiare con me.
Le due condizioni sono contemporaneamente pregiudiziali.
Senza un minimo di stabilità sull’identità non c’è scambio, ma solo svuotamento e liquefazione. Il nucleo fondamentale stabilizzante è costituito dalla passione per la causa di Gesù, che deve riempire tutta la vita di un giovane sacerdote.
Per comprendere progressivamente il significato, per organizzare le scelte e impegnare le energie in gesti concreti, abbiamo bisogno del confronto e dell’arricchimento che mi regala chi vive la stessa passione secondo modalità diverse dalle mie.
Quando la meta è la vita e la speranza, tutti hanno cose preziose da scambiare con me.
Per questo stimo urgente abilitarci al confronto con la diversità, proprio per consolidare la personale originalità e farla crescere verso il futuro.
Fare formazione significa programmare tempi e modalità proprio in questa direzione: sperimentarla quasi in laboratorio, per diventare capaci di viverlo nella fatica di quel tempo, dove la trama delle cose sembra quasi toglierci il respiro.
Ho incontrato giovani preti, formati in seminari dove si vive così. E ne ho incontrati tanti che invece sono sicuri su tutto, giudicano prima di confrontarsi, selezionano i riferimenti e condannano con la stessa facilità con cui i discepoli di Gesù dovrebbero amare.
Se questi secondi non stanno con i giovani, ringrazio il Signore, a nome dei giovani, che non hanno la sfortuna di incontrarli.
Un’ultima cosa desidero dire.
Lo scambio non può avvenire nel rumore della piazza. Lì avviene l’incontro e il confronto. Lì si accumulano le informazioni. La formazione trasforma le informazioni e le provocazioni in struttura di identità, attraverso la capacità di interiorità (che è ascolto del mistero di Dio, preghiera, meditazione e contemplazione quotidiana). Senza interiorità, sofferta e conquistata, il vento della confusione travolge e la personalità incerta viene schiacciata.
Mi piacerebbe che molte delle energie impegnate nel tempo della formazione fossero giocate per abilitare alla interiorità.
Lo so che non è facile in questa nostra stagione culturale, ma nessuno mi può togliere il diritto di sognare.
Domanda. I processi di formazione, non solo nei seminari, ma anche nel periodo precedente o in quello immediatamente successivo, già nel lavoro pastorale, sembrano soltanto di tipo intellettuale, astratto, deduttivo o, se vissuto in un tirocinio o in esperienze concrete, non è assistito da esperti, magari dagli stessi docenti di PG del seminario. E il giovane prete si sente solo, con un compito magari esaltante, ma anche solitario. E sente che forse lui stesso non ha risolto gli stessi problemi che gli pongono i giovani. Quale tipo di esperienze e accompagnamento?
Pollo. È chiaro, sulla base delle cose sin qui dette, che un elemento centrale della formazione dovrebbe essere costituito da esperienze di “tirocinio” guidate da dei supervisori esperti, che aiutino il giovane prete, da un lato ad avviare quel cambiamento interiore che è il primo passo della scoperta delle interazioni autentiche, e dall’altro lato a tradurre in soluzioni operative valide il sapere che ha accumulato nei suoi studi, unitamente all’aiuto a colmare le lacune che sono presenti nella formazione.
Tutte le professioni di aiuto e educative prevedono questo tipo di tirocinio che, anche se non può essere ritenuto miracoloso, ha comunque un elevato grado di efficacia.
La supervisione, più che ai docenti di PG, dovrebbe essere affidata a persone che uniscono la conoscenza dell’azione sul campo, perché vi hanno operato e continuano ad operarvi, con una buona maturità personale e una buona conoscenza dei fondamenti teorici della PG o dell’educazione.
Ma non solo. Anche dopo il tirocinio, il giovane prete dovrebbe avere un supervisore da cui periodicamente recarsi, così come ce l’hanno gli psicoanalisti o, più semplicemente, i buoni educatori.
Bissoli. Ho già detto sufficientemente prima. Qui annoto che una chiesa assume la questione giovanile, più che come problema, come risorsa (risorsa di professionalità, risorsa di amore e generatività, risorsa vocazionale, risorsa missionaria, risorsa di governo sociale), e sotto questa prospettiva ne parla a tutti i membri della comunità, sistematicamente, facendo conoscere la comunità ai giovani e i giovani alla comunità. In particolare, la chiesa prende cura degli animatori laici (adulti) che, con il giovane prete, ma non senza la partecipazione convinta del parroco, si rendono disponibili a servire i giovani, unendo insieme, sia pure articolatamente, fanciulli, preadolescenti, adolescenti, giovani.
Al giovane prete va data la possibilità (e quindi l’obbligo) di un corso formativo e di stage periodici di aggiornamento, a cura della PG diocesana, a nome del Vescovo; gli si chiede conto del programma, lo si sostiene e gli si offrono occasioni specifiche di conversare con i colleghi animatori, con esperti prefissati, con il proprio vescovo. Come un albero inizia da lontano, occorre che la PG attecchisca nel cuore dei futuri preti in tempi lunghi, per lo meno quando vengono in seminario e iniziano il cammino verso il sacerdozio. Sarà anche inizio di cammino verso i giovani.